Helios
« Zeus padre, signore dell’Ida, grande e glorioso,Sole che tutti vedi e tutto ascolti,fiumi e terra, e voi che sotto terrapunite da morti coloro che giurano il falso, siate testimoni, e custodite i patti. »
Omero, Iliade, III, 276-280.
Nell’Iliade troviamo il più antico
riferimento al dio Helios, per i Greci il
dio dell’Astro solare, che è trasportato su un carro guidato da Apollo che
sfreccia nel cielo, portando la Luce nel suo viaggio cosmico, da oriente ad
occidente così da permettere il compimento de giorni che vengono rischiarati con la sua Luce. Apollo chiamato
dagli stessi Greci “Febo”, ovvero splendente, lucente, raggiante, radioso, era il fratello gemello di Artemide, la Luna,
e nacque dall'amore di Zeus e Latona . Spesso fu identificato con Helios, da
Euripide in poi, mentre i poeti più antichi facevano una netta distinzione tra
i due: Apollo era il dio della salute, della poesia e del canto ed Helios era una
divinità solare. Helios, in particolare,
come dio dell’Astro solare era
considerato fonte di vita e di luce di
cui gli esseri umani non potevano fare a meno; contemporaneamente era però
percepita come una divinità lontana dalla Terra, anche se la sua azione
condizionava fortemente la vita degli
stessi uomini perché
allontanava le tenebre che spesso
associate all’idea del male. Tale condizione, ovvero quella di un dio che
sconfiggeva il male e faceva trionfare il bene e la Luce, era talmente centrale
per gli antichi, che ben presto
determinò la nascita di nuovi culti, come quello del Deus Sol
Invictus, legato alle feste che celebravano la “nascita del Sole” molto diffuse
in Grecia e poi anche nel mondo latino.

Efesto
“ ..Verrò dimani al raggio mattutino,e recherotti io stessa una forbita
bella armatura di Vulcan lavoro…”
“…Io salgo a ritrovar l’inclito
fabbro
Vulcano, e il pregherò che luminose
armi stupende al figlio mio conceda…”
vv. 181-183 e vv. 189-191 libro XVIII
Iliade
Sempre nell’Iliade è presente
Vulcano, Efesto, identificato in Vulcano
dai Romani, divinità del fuoco, delle
fucine e della metallurgia che, grazie alla sua azione e al suo lavoro nel
ventre dell’Etna, faceva in modo che la
Luce divenisse un elemento quotidiano,
usuale, familiare. La Luce emessa si mostrava sia come elemento positivo,
perché collegata all’idea della vita, sia come segno di paura, di terrore, perché si credeva che i Ciclopi, aiutanti del dio, con i
colpi inferti sulle incudini generassero
i rumori che fuoriuscivano dalle bocche del vulcano stesso. Quindi, la Luce, centrale
nell’opera di Efesto/ Vulcano, è l’elemento che dà vita ma che allo stesso
tempo distrugge e intimorisce. Il potere
della Luce era tale che gli antichi ritenevano opera del dio anche i magnifici oggetti che ornavano gli dèi, le
armi splendenti che nei miti accompagnavano e difendevano gli eroi, uno tra
tutti Achille, al quale il dio fabbrica le nuove armi dopo la morte di
Patroclo.I Greci sono stati inoltre uno
dei popoli che ha determinato la nascita
di una sorta di “metafisica della Luce”; sono partiti dalla Luce come fenomeno naturale
per indagare i suoi molteplici aspetti: la Luce come dispensatrice di vita e
salute, che vince il male e le tenebre e che, quando è assente, genera il buio in grado di sconvolgere l’ esistenza degli uomini.

I Greci sono stati
inoltre uno dei popoli che ha
determinato la nascita di una sorta di “metafisica della Luce”; sono partiti dalla Luce come fenomeno
naturale per indagare i suoi molteplici aspetti: la Luce come dispensatrice di
vita e salute, che vince il male e le tenebre e che, quando è
assente, genera il buio in grado di sconvolgere l’ esistenza degli uomini. L’indagine sulla Luce contempla quindi anche
il suo lato negativo ed oscuro tale da provocare timore e riverenza nei suoi
confronti. Inoltre, la Luce si presta a molteplici
interpretazioni simboliche, perché si pone come elemento in continuo movimento
e trasformazione e perciò è collegabile con tutta la dinamica esistenziale
dell’uomo greco che crea ed interpreta
i miti per indagare la realtà, per
cercare e dare risposte e che, con la
filosofia, ha cercato di collegare lo sviluppo del pensiero e del sapere con la
concretezza delle azioni.


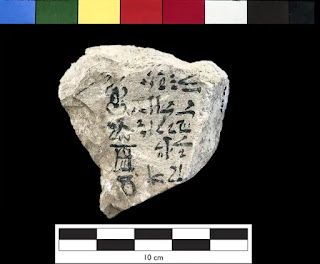
Commenti
Posta un commento